Microalghe ad alta efficienza fotosintetica contro l'inquinamento atmosferico. Una struttura multifunzionale purifica l'aria e offre arredo urbano sostenibile.
L’Unesco ci dice che le montagne ospitano circa la metà della biodiversità presente oggi in natura e oltre la metà degli abitanti della Terra utilizza acqua proveniente dalle montagne, esse coprono circa il 27% del nostro pianeta. La loro conservazione è fondamentale per garantire la vita e lo sviluppo del pianeta e rientra nell'Obiettivo 15 dell'Agenda ONU 2030, dedicato alla “vita sulla terra”.
Per promuovere la loro conservazione, le Nazioni Unite hanno istituito l'11 dicembre come Giornata Internazionale della Montagna.
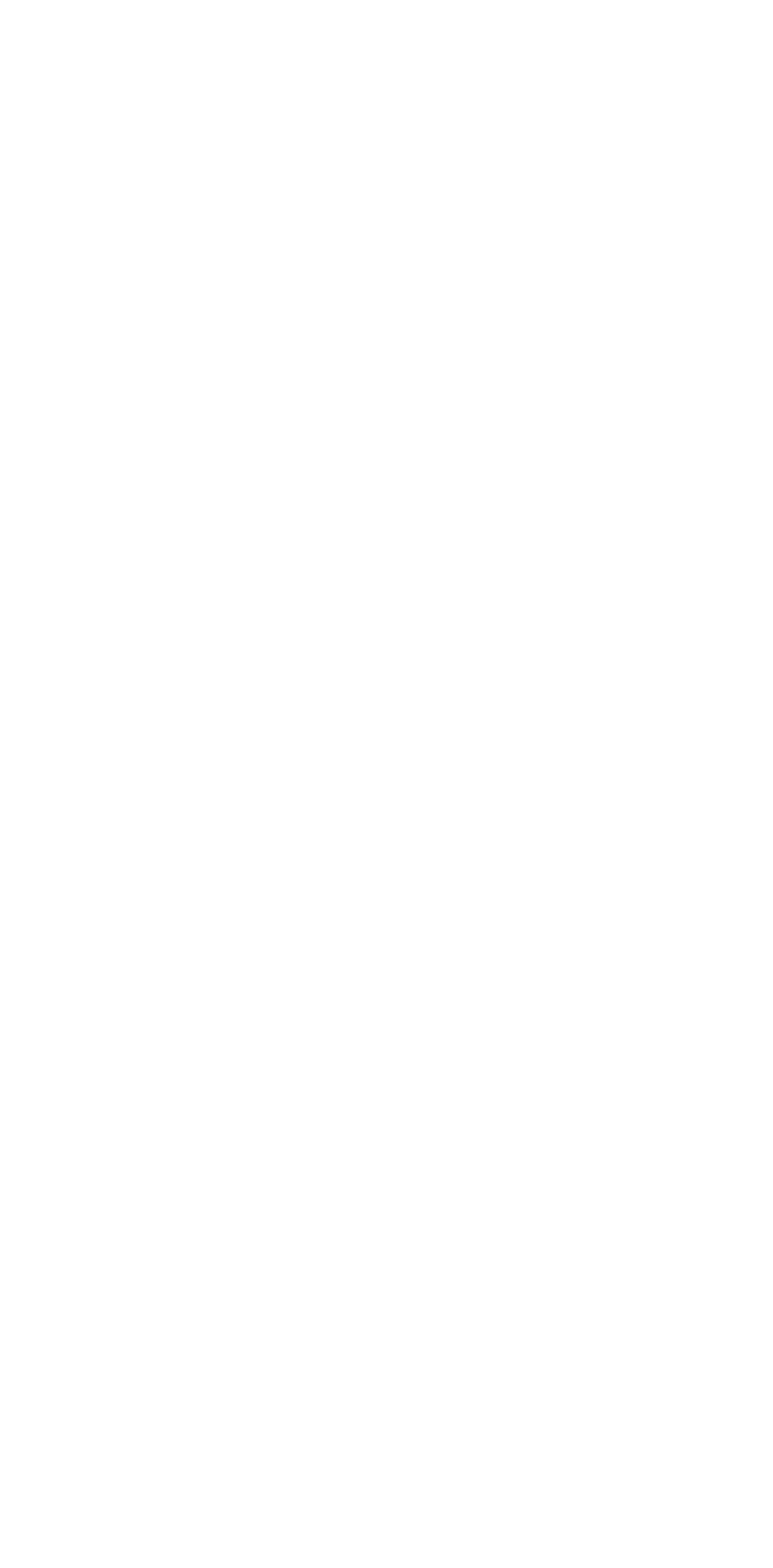
Il progetto MountResilience si inserisce nella Missione dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici, ed è guidato dal Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, attraverso il suo polo d'eccellenza UNIMONT, parte integrante di Horizon Europe, il programma quadro di ricerca e innovazione.
Il progetto si propone, in prima istanza, di raccogliere informazioni, dati, case history ed evidenze scientifiche ad ampio spettro, per implementare un Big Data intelligente su cui elaborare modelli e simulazioni delle possibili azioni di adattamento. L'obiettivo è di identificare e testare nuove tecnologie e approcci che possano contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e aumentare la resilienza delle comunità locali.
Abbiamo incontrato Anna Giorgi, Professore Ordinario, Delegata del Rettore alla promozione delle attività per la valorizzazione del territorio montano e Responsabile Polo UNIMONT.
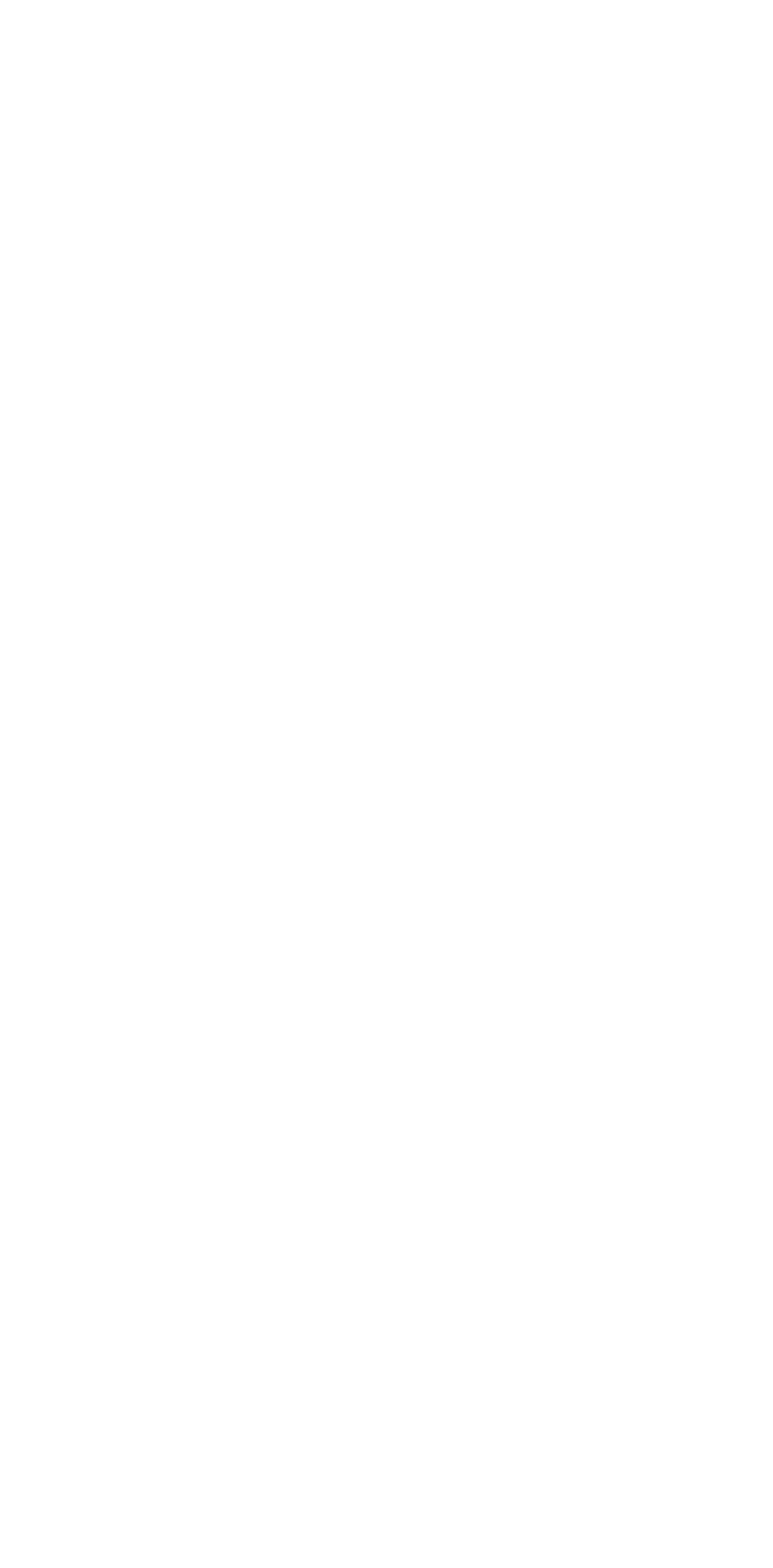
“Gli obiettivi del progetto MountResilience sono molteplici, quanto è vasto e diversificato l’orizzonte d’applicazione. Mira a sfruttare le diversità territoriali per integrare una vasta gamma di prospettive, conoscenze ed esperienze. Sono coinvolte 47 organizzazioni partner provenienti da 12 Paesi europei: Austria, Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna, Romania, Spagna, Svizzera. L’approccio multidisciplinare è fondamentale per generare un portfolio variegato di proposte e strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici, e massimizza il suo potenziale di replicabilità in Paesi e contesti diversi. Le aree montuose della Finlandia e quelle della Romania hanno evidenze e sfide ben diverse tra loro, la prima è proprio quella di fare sistema di esperienze e dati disomogenei.
La risorsa idrica e la gestione del turismo rappresentano i focus critici più immediati ed evidenti. Due elementi strettamente interconnessi.
La gestione dell'acqua comprende l'agricoltura, la zootecnia, ma anche il turismo legato alla neve e al ghiaccio, così come la produzione di energia idroelettrica nonché la fornitura di acqua potabile.
Grazie all’utilizzo di Big Data e di algoritmi di machine learning è possibile effettuare un’analisi climatica dello storico, precipitazioni comprese, ed elaborare modelli di proiezione delle prossime stagioni.

Sistemi di sensori monitorano invece lo stato delle risorse idriche superficiali e sotterranee, evidenziando trend e disponibilità di acqua per prevedere quando e se è necessario intervenire.
L’utilizzo di tecnologia e AI è cruciale: piattaforme tecnologiche digitali raccolgono e lavorano dati e informazioni pluri sorgente, e in tempo reale restituiscono strategie e piani d’azione di utilizzo efficiente delle risorse. Decison making pulse, definiamo questo processo. L’istruzione di questa piattaforma è appannaggio dei partner Svizzeri.”
Lo sci su piste con innevamento artificiale è diventato, ormai da decenni, pratica comune del turismo invernale, ma solleva preoccupazioni riguardo all'inquinamento ambientale e al consumo di risorse. Per mantenere le piste innevate, vengono utilizzati enormi quantità di acqua ed energia.
Secondo CIPRA - Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, durante una stagione invernale vengono consumati circa 95 mln di m3 d'acqua e spesi 600 gigawattora di energia, con un costo economico significativo. La neve artificiale ha inoltre un peso maggiore e una minore capacità isolante rispetto alla neve naturale e può causare il congelamento del suolo e l'asfissia delle piante. Una conseguenza evidente è il ritardo che spesso si evidenzia nell'attività vegetativa nelle zone con innevamento artificiale.

In quota, si stanno costruendo sempre più bacini di raccolta e stoccaggio dell'acqua piovana o di fusione per poterla utilizzare durante l'inverno con i cannoni sparaneve. A volte, in urgenza, si esplorano anche soluzioni bizzarre, come il trasporto della neve su elicottero, come a Cortina nel 2022.
Nel contesto dello studio delle soluzioni per ridurre l'impatto ambientale dell'innevamento artificiale, si sta considerando l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile per alimentare le strutture, e pratiche di riciclo e riutilizzo delle acque utilizzate dai cannoni.
Un esperimento interessante è stato fatto durante le Olimpiadi in Cina, dove sono state introdotte sofisticate tecnologie di refrigerazione utilizzando CO2 naturale, alimentate da energia pulita. Questo ha permesso di ridurre significativamente le emissioni di carbonio associate al processo di raffreddamento dell'acqua e una riduzione dei consumi energetici. É stato implementato anche un sistema per raccogliere l'acqua derivante dalla neve artificiale e convogliarla in serbatoi locali, consentendo così il suo recupero e riutilizzo.
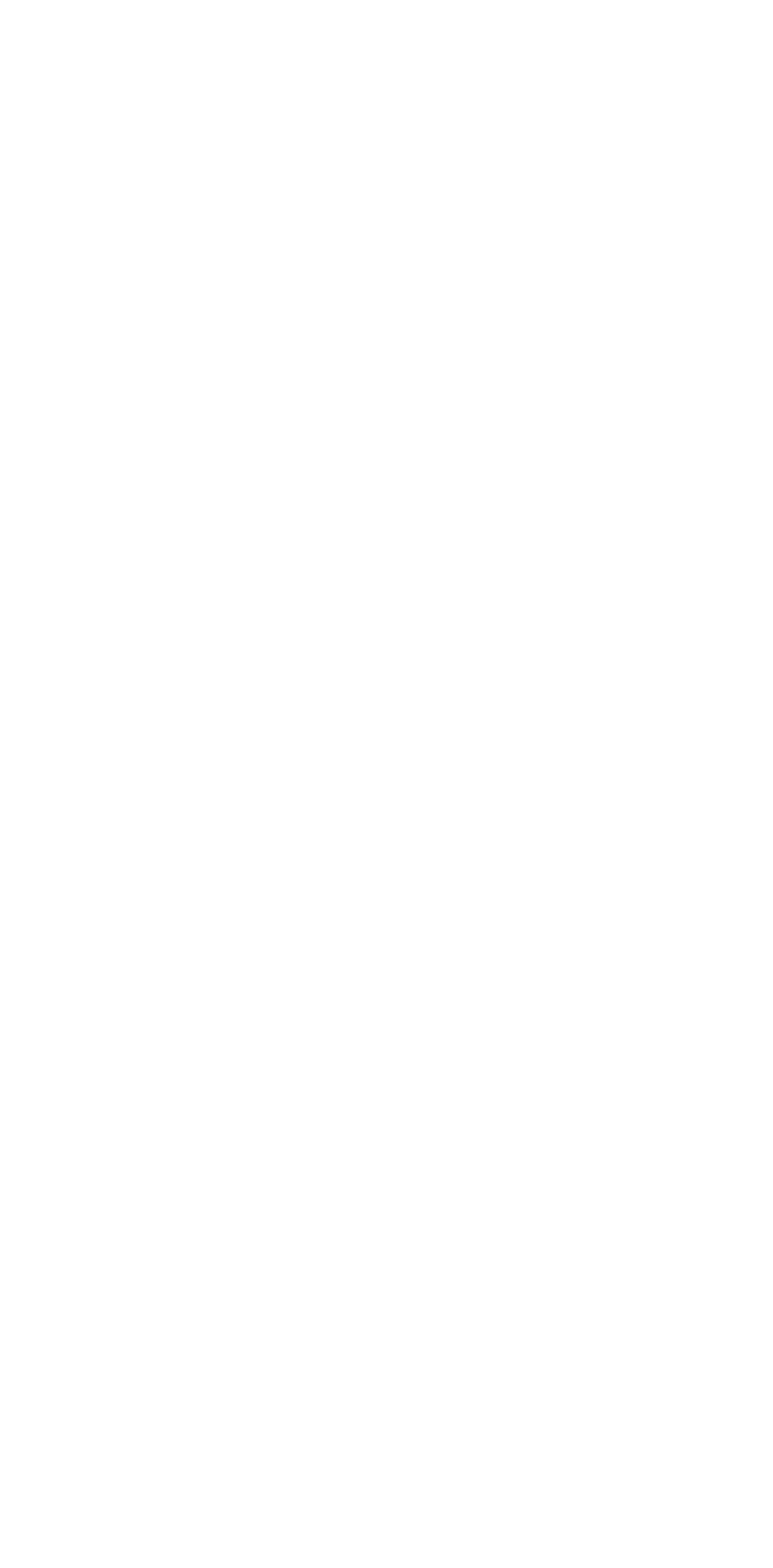
“La questione della neve artificiale è una questione estremamente delicata.
In tutto l’arco alpino, le località con gli impianti sciistici più importanti e che storicamente hanno basato la propria economia sullo sci, e relativo indotto, sono anche le più note. Ed è un turismo ancora consistente, sebbene cambiamenti climatici e costi energetici rendano questo sport sempre più costoso. Chiudere tutto avrebbe un impatto economico e ideologico non affrontabile nell’immediato.
D’altro canto, i cannoni da neve sono sempre più performanti ed efficienti, in termini di acqua ed energia, e oggi funzionano anche a temperature più miti rispetto al passato.
Per quanto supportati da modelli previsionali e strumenti di intervento preventivi, è comunque necessario parallelamente, promuovere un cambiamento collettivo dello stile di vita. Non possiamo ripristinare l’ambiente al pre climate change.
Temperature e biodiversità sono destinate a continuare a modificarsi: gli allevamenti di renne in Finlandia stanno subendo grossi contraccolpi e di questa carne il popolo si nutre da secoli. Anche la Romania, che basa buona parte della propria economia sulla zootecnia, vede modificarsi la composizione dei pascoli, poiché molti pastori si avventurano più in alto, altri abbandonano l’attività.
E se lo sci non sarà più uno sport facilmente praticabile al di sotto dei 2000 metri, le comunità locali dovranno trovare il modo per transitare verso una trasformazione del modello economico, fornendo servizi diversi che permettano alle persone di trascorrere del tempo piacevole in montagna. Il nostro compito è anche quello di supportare la conversione dei modelli economici dove le stazioni sciistiche non hanno un futuro: promuovere un adattamento intelligente seguendo il benessere generale, trascurando, a volte, interessi contingenti e particolari.”
Microalghe ad alta efficienza fotosintetica contro l'inquinamento atmosferico. Una struttura multifunzionale purifica l'aria e offre arredo urbano sostenibile.
Biome Makers migliora la salute del suolo e la produttività agricola combinando analisi del microbioma del terreno e Intelligenza Artificiale.
